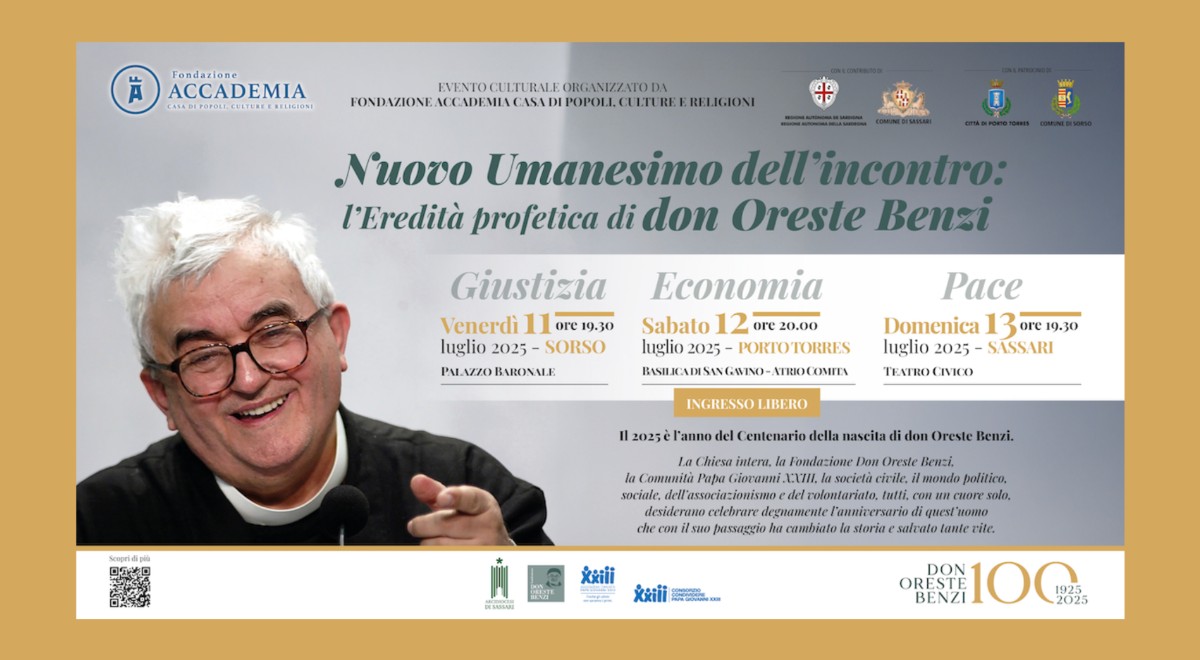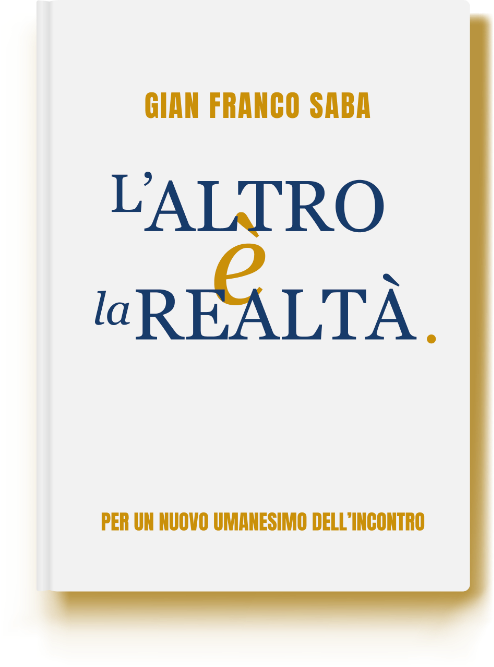- Cosa è Fondazione Accademia
- Alta Formazione
- Formazione in generale
- Un mondo più inclusivo e iniziative sociali
- Iniziative culturali e di ricerca
- Spazi di incontro e condivisione
- Seminario Internazionale di ricerca Religioni e testi sacri
- Simposio Internazionale Popoli, Culture e Religioni per un Nuovo Umanesimo